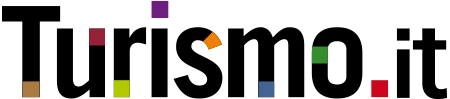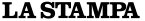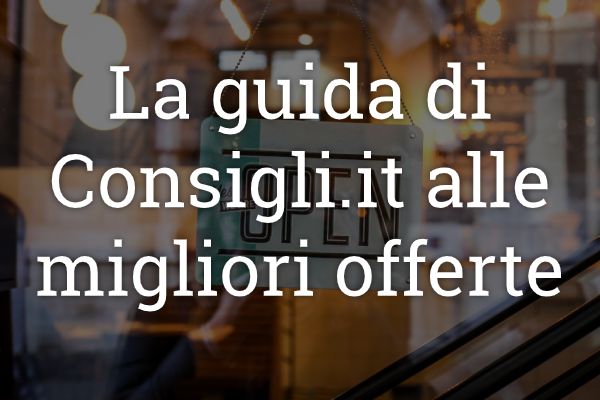Veduta di Salemi con il Castello e la bandiera tricolore sulla torre cilindrica
Quattro passi per il borgo
E proprio il Castello Normanno Svevo, fatto costruire tra il 1070 e il 1130 in Piazza Alicia, nel punto più alto della città. Voluta da Rugger il Normanno è oggi una delle più visitate attrazioni turistiche anche per il atto che dalla torre cilindrica si ha una veduta panoramica mozzafiato. La struttura, nel corso dei secoli, ha cambiato destinazione d’uso diventando anche carcere e biblioteca comunale fino a quando, dopo diversi lavori di restauro, dal 2010 è stato trasformato in sede per mostre ed eventi. Sulla stessa piazza del castello si trovano anche i suggestivi resti dell’ex Chiesa Madre (nella foto sotto), danneggiata dal terremoto del 1968, ragion per cui non ci sono tetto e pareti ed oggi appare più come un’opera incompiuta che come luogo di culto. La Chiesa Madre attuale si trova in Via Francesco D’Aguirre, ed è dedicata a San Nicola, che spicca per la sua facciata barocca, arricchita da bellissime colonne in tufo. Al suo interno si può visitare il Museo Civico, dove sono raccolte varie opere religiose che furono salvate durante il terremoto del Belice del 1968. Altra interessante attrazione è il Museo del Pane Rituale (qui per maggiori informazioni) dove si può scoprire la storia del pane rituale. Questo museo particolare nasce con l’intento di far conoscere l’importanza e le tradizioni legate al pane, con particolari curiosi come il fatto che non si posava a testa in giù e che in Sicilia tutte le feste venivano celbrate con il pane di produzioni differenti che variavano da paese a paese, alcune forme finemente lavorate, altre molto semplici ma tutte piene di significato. Oggi molte di queste tradizioni sono state perse, ma non a Salemi, che riesce ancora a conservarle con un ciclo che inizia il 17 gennaio e finisce a Natale. Il Museo del Pane Rituale è diviso in due sezioni: Pani della tradizione salemitana e pani della tradizione siciliana per un totale di circa 1.000 forme.

Piazza Alicia, le suggestive rovine della ex Chiesa Madre di Salemi
I dintorni di Salemi
Dopo la scoperta del borgo vale la pena spostarsi anche di pochi chilometri per immergersi in alcuni interessanti siti archeologici come quello di Mokarta dove sono stati scoperti una necropoli che ospita circa un centinaio di tombe scavate nella roccia, ed un insediamento risalente alla tarda Età del Bronzo. Vi si trovano poi anche i ruderi di un castello arabo normanno nonché di mura di antiche abitazioni sul Monte Polizo. In contrada San Miceli c’è anche una basilica paleocristiana risalente al III-IV secolo d.C. A poco più di 7 chilometri si trova Gibellina, che nel 1968 fu completamente distrutta da un violento terremoto spazzando via l’antico centro agricolo di origine medievale. Quella che si ammira oggi è una città-giardino con grandi vie ed ampi spazi e la grande Stella, un’enorme struttura simbolo di rinascita, che funge da porta della città nuova ed è visibile da molto lontano. Gibellina è un museo dell'architettura e dell'arte moderna: ne sono un esempio, oltre alla Porta Belice, la Chiesa Madre, i Giardini Segreti, Piazza XV gennaio 1968 con la Torre Civica-Carrilion, e tante altre opere.
Vieni a scoprire di più su Gibellina

Meridiana di Gibellina
Salemi è conosciuta anche come la Città dei Pani per la meticolosa lavorazione dei pani devozionali serviti sugli altari votivi durante le celebrazioni religiose più sentite, ovvero la Festa di San Giuseppe, la Festa di Sant’Antonio Abate e la Festa di San Biagio. Durante queste celebrazioni si possono gustare anche cuddureddi e cavadduzzi, piccoli pani in miniatura a base di acqua e farina, non lievitati e cotti in forno, e sfinci, palline d’impasto dolci ricoperte di zucchero. Ciò che rende davvero speciali cuddureddi e cavadduzzi è la maestrìa con cui vengono minuziosamente decorati grazie a particolari intagli creati con la punta di un coltellino detto “mucacia”. Questi piccoli capolavori ripercorrono, nella forma e nel nome, alcuni episodi salienti della vita di San Biagio. I primi simboleggiano la gola, di cui il santo è protettore: tradizione vuole che salvò la vita di un ragazzo che stava morendo soffocato da una lisca di pesce, mentre i cavadduzzi, a forma di cavallette, ricordano un avvenimento del 1542 accaduto durante il regno di Carlo V, quando, per intercessione di San Biagio, le campagne salemitane furono liberate da un’invasione di sciami di cavallette che distrussero il raccolto e ciò gli valse il “titolo” di compatrono della città di Salemi. Da allora, ogni anno, si riproducono questi pani artistici come segno di ringraziamento. I cavadduzzi, però, oltre a rappresentare le cavallette, possono assumere le forme più disparate, frutto dell’estro creativo dei panificatori: si va dai cavallucci marini o altri piccoli animali anche immaginari fino a parti del corpo del santo come il braccio e la mano benedicente.