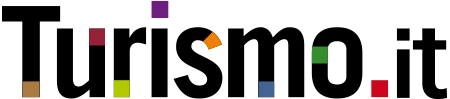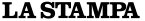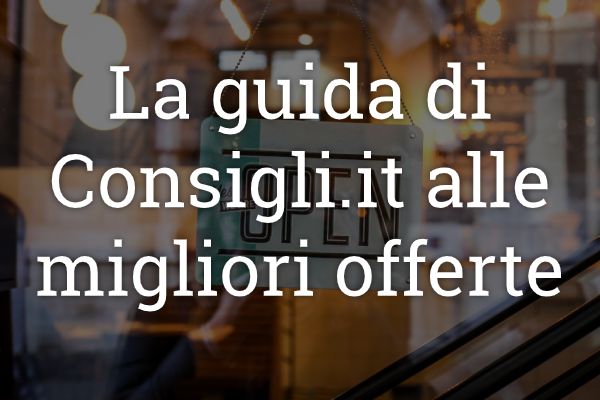Ma innanzitutto, qual è il collegamento tra antichi Greci e Polesine? La civiltà greca giunse fino a queste latitudini: anche se le sue più importanti colonie si trovavano al sud d’Italia (la Magna Grecia), anche in queste zone dove la Pianura Padana incontra il mare vi furono degli importanti insediamenti ellenici. I Greci (anzi, gli abitanti greci delle poleis siciliane) fondarono per esempio Adria su quello che già era un importante insediamento Etrusco, cittadina dalla quale il Mare Adriatico si presume abbia derivato il suo nome. Si trattava di un porto molto importante all’epoca, situato in una posizione strategica per dominare il grande golfo dell’Alto Adriatico. Allora – ci troviamo tra il XII e l’XI secolo a.C. – le acque di un ramo del delta del Po, chiamato Po di Adria, scorrevano proprio qui.

Paesaggio del delta
Leggi anche: 5 passeggiate in bicicletta sul Delta del Po veneto
Miti greci sul Delta del Po
Insomma, i Greci frequentarono queste zone e il Delta del Po e, non a caso, ambientarono qui uno dei loro miti più celebri. Fetonte era il figlio del dio del Sole, Elio, e di Climene, divinità delle acque e dei mari (altre versioni del mito gli attribuiscono diversa maternità). Sfidato da un coetaneo, Epafo, a provare la sua discendenza paterna, il giovane Fetonte ottenne da Elio il permesso di guidare l’iconico carro del Sole per un giorno. Tragico e arcinoto è l’epilogo della vicenda: Fetonte, incapace di mantenere salde le redini a cui erano legati i cavalli che trainavano carro, perse il controllo e finì troppo vicino alla Terra, arrecando numerosi danni. Una siccità improvvisa prosciugò fiumi, bruciò foreste, incendiò vasti territori tanto che secondo la mitologia greca così si formò il deserto africano, e da lì in avanti la pelle degli Etiopi divenne nera. Zeus si infuriò, e, sconvolto dai danni provocati dall’inetto Fetonte, colpì il carro con il suo proverbiale fulmine e lo scagliò lontano, fino a farlo cadere nelle acque del fiume Eridano, dove morì.
Ebbene, il punto in cui si dice essere caduto e annegato Fetonte corrisponde al tratto di Po che lambisce Crespino, paese della provincia di Rovigo che si trova proprio sotto l’argine del fiume. Il corso d’acqua era infatti un tempo chiamato Eridano, nome che nel greco antico si attribuiva ai fiumi mitici. La storia di Fetonte viene narrata da numerosi poeti classici, e si ritrova anche nel racconto degli Argonauti, gli eroi che compirono un avventuroso viaggio nel Mediterraneo in cerca del Vello d’Oro. Le loro peregrinazioni li portarono ad un certo punto lungo il fiume Eridanio, dove ancora giaceva fumante il corpo di Fetonte, le cui esalazioni erano talmente orribili da far morire gli uccelli: da qui nasce l’espressione ‘fetido’ o ‘fetente’.

La piazza di Crespino
Si dice inoltre che le sorelle di Fetonte, le Eliadi, giunsero a Crespino e si radunarono sulle rive del fiume per piangere il fratello, trasformandosi per il dolore nei pioppi che ancora oggi punteggiano le sponde del Po, mentre le loro lacrime si mutarono in ambra. Il Polesine, all’epoca, faceva infatti parte della ‘via dell’ambra’, una complessa rete di scambi commerciali che collegava la Grecia ai paesi dell’entroterra europeo. Si dice che alcune isole formate dai rami del delta potrebbero essere le mitiche Elettridi – elektron dal greco ‘ambra’.
Leggi anche: A Rovigo un museo dedicato ai Grandi Fiumi
La Rovra
Non è un mito greco, ma un altro curioso aneddoto leggendario ha come cornice il Delta del Po veneto. Ad Ariano nel Polesine, nei pressi della località di San Basilio, sulle rive del Po di Goro (uno dei rami del delta) c’era fino a pochi anni fa una quercia secolare - come riporta il WWF, morta di cause naturali. Questa quercia era un vero e proprio monumento polesano, ed era chiamato dai locali ‘la Rovra’. Oltre ad essere un celebre punto di rifermento per le guide e i visitatori, e rappresentare un patrimonio ambientale oramai quasi completamente perduto, la rovra aveva creato attorno a sé un mito che riguardava Dante Alighieri. Il sommo poeta infatti si sarebbe trovato disperso tra le terre e le acque di questi luoghi, e sarebbe salito in cima alla rovra per scrutare l’orizzonte e ritrovare il cammino. Si tratta di un episodio mai accertato storicamente, ma che i polesani custodiscono gelosamente, tanto che non esitano a chiamarla 'la quercia di Dante'.