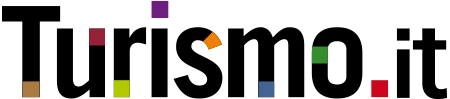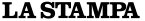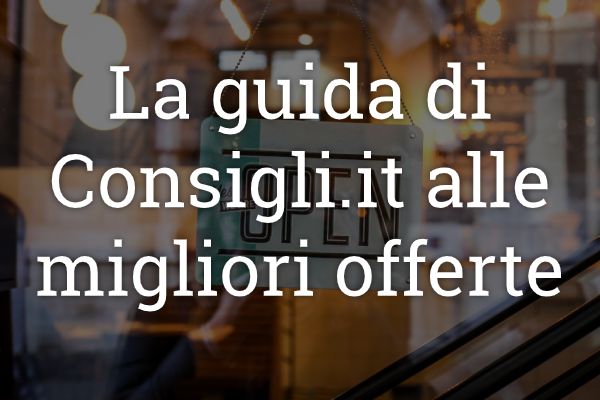Pulcinella suona il mandolino
I “genitori” del mandolino napoletanoL'intera famiglia si dedicò all'arte della liuteria dando i natali a numerosi liutai che hanno fatto la storia di questo strumento tra i quali Gennaro (attivo tra il 1755 e il 1784) e i suoi figli Antonio, Vincenzo (attivo tra il 1767 e il 1802) e Giovanni (attivo tra il 1767 e il 1777), Gaetano Vinaccia (attivo tra il 1779 e il 1821), figlio di Antonio, e Pasquale (1806-85), che realizzò i primi mandolini con corde di acciaio e meccaniche, furono i membri che apportarono maggiore contributo all'evoluzione dello strumento. Alla bottega dei Vinaccia, attiva al n. 46 di Rua Catalana, si andarono via via affiancando quelle di nuovi maestri liutai che, soprattuto nel periodo tra il 1720 e il 1820, conferirono ancor più prestigio ai mandolini napoletani la cui fama oltrepassò abbondantemente i confini del Regno. Basti pensare che gli Zar russi giunsero sino a Napoli per cercare un maestro mandolinista da far lavorare a corte. La scelta ricadde, infine, sul mandolinista Eduardo Amurri. Nello stesso periodo si assistette all'ascesa di un'altra prestigiosa famiglia di liutai che operò nello stesso periodo dei Vinaccia. Si tratta dei fratelli Fabbricatore che, succeduti dai loro discendenti, fecero parlare di sé per ben due secoli grazie alla produzione di chitarre e mandolini napoletani di qualità ed alla stampa di musica. I loro strumenti, prodotti soprattutto nel periodo a cavallo tra la fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX secolo, si distinguevano per l'eleganza delle forme e dei decori caratterizzati dall'utilizzo di materiali di elevato pregio come tartaruga, avorio, madreperla ed elaborati fregi sulla cassa accanto al ponticello.

Mandolino di Antonio Vinaccia
Dalle orchestre di corte alla musica popolareGià dalla seconda metà del XIX secolo la musica del mandolino aveva ormai conquistato un vasto pubblico, specialmente nell'ambito dei ceti più elevati, come l'aristocrazie a l'alta borghesia. Persino la Regina Margherita ne era un'estimatrice oltre ad essere un'abile musicista che si dilettava a corte con un'orchestra si strumenti a plettro. Quando la diffusione della canzone napoletana, che lo scelse come accompagnamento, lo rese fin troppo popolare, i nobili e gli aristocratici cominciarono a perdere interesse per la sua musica che sino ad allora aveva potuto contare su autori di grande prestigio tra cui Vivaldi, Mozart, Beethoven, Paisiello, Händel e Verdi. Fu proprio nel XIX che l'altra grande famiglia del mandolino napoletano intraprese la propria attività. Si tratta della famiglia Calace il cui capostipite, Nicola, cominciò a realizzare i propri strumenti a Procida dove viveva confinato per ragioni politiche, ottenendo un certo successo nonostante la concorrenza di liutai del calibro dei Vinaccia e dei Fabbricatore. Alla sua morte furono i figli Antonio e Raffaele a prendere le redini dell'attività di famiglia trasferendosi a Napoli. La rivalità tra i due fratelli creò, però, dissidi insanabili che portarono Antonio ad emigrare in America dove portò avanti la sua arte liutaia assieme ad un altro italiano, Nicola Turturro. Il fratello Raffaele rimase in terra partenopea distinguendosi per le sue doti di liutaio e compositore tanto da essere definito “il Paganini del mandolino” e da realizzare ottimi mandolini sui quali brevettò alcune importanti modifiche come l'introduzione della meccanica in acciaio e l'allungamento della tastiera da ventiquattro a ventinove tasti, con la speranza di riuscire a rendere lo strumento adatto ai programmi da concerto. Il tentativo si rivelò, però, vano perchè ormai il mandolino aveva assunto quella immagine di strumento popolare che ancora oggi lo contraddistingue. I discendenti portarono avanti la tradizione di famiglia tenendo alto il nome dei Calace che ancora oggi viene associato al mandolino napoletano di pregio. Delle grandi famiglie dei liutai napoletani è l'unica ancora in attività.

Ceramiche di Capodimonte
Le eccellenze dell'artigianato campanoI suoni a volte dolci, a volte sbarazzini e spensierati del mandolino napoletano custodiscono, quindi, una storia lunga e di grande prestigio che ha consentito agli artigiani napoletani di distinguersi anche nel campo dell'arte liutaia. E non c'è da meravigliarsene perchè l'abilità degli artigiani campani è ben nota e si è distinta in numerosi settori, specialmente in quello della lavorazione di ceramica e terracotta. Come non pensare, ad esempio, alle opere d'arte in porcellana di Capodimonte, note sin dal XVIII secolo, realizzate all'interno dell'omonima reggia alle porte di Napoli (ve ne abbiamo parlato qui), alle eleganti maioliche di Ariano Irpino, alle quali è dedicato un intero Museo (leggi qui per saperne di più), o alle variopinte ceramiche di Vietri, che sprigionano tutti i colori dell'assolata Costiera Amalfitana. Anche il mare ha voluto contribuire al lustro degli artigiani campani offrendo il corallo dal quale si ricavano le pregiate lavorazioni tipiche della tradizione di Ravello e di Torre del Greco. Il corallo, oltre tutto, è uno dei materiali tradizionali con cui a Napoli vengono realizzati i tipici cornetti portafortuna, un'altra delle caratteristiche creazioni legate al folklore locale da acquistare nelle botteghe artigiane che si affacciano su via di San Gregorio Armeno, famosa per le sue statuine da presepe che riproducono i soggetti più svariati (ve ne abbiamo parlato qui).
DA VEDERE A NAPOLI: VAI ALLA GUIDA
Leggi anche:
Pompei, la meraviglia d'Italia più a rischio
Quei pomodorini "rosso Vesuvio"
Oltre Pompei ed Ercolano
CONSIGLI PER IL WEEKEND
I PIU’ BEI MONUMENTI ITALIANI DA VISITARE